Come sempre per il cinema di David Lynch, alla fine del film è più facile trovare una formula che contenga le sensazioni provate, un titolo da dare alla recensione, piuttosto che argomentare logicamente la storia narrata.
Campi di Visione. Un film brutto, non un brutto film. Vedo me stesso. Logica del non-sense. La deriva dell’immaginario.
Essere dei fans, o anche dei semplici estimatori/sensibili spettatori del cinema del Nostro, facilita l’appeal di un film che poco ha a che spartire con il cinema, e con il cinema dello stesso Lynch in particolare. O forse anche questa è solo un’impressione.
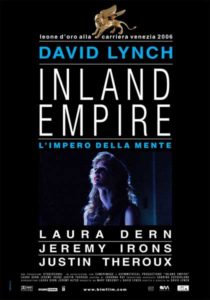 Ripartendo da Mulholland Drive, appare evidente come Lynch insista ancor di più su quella dis-misura della narrazione che aveva disorientato i più. In INLAND EMPIRE, infatti, la rottura data dall’apertura del cubo blu non avviene dopo due ore di film e a venti minuti dalla fine, ma dopo solo un’ora, forse cinquanta minuti, dall’inizio del film. E si tratta di una rottura che non consente ritorni, neanche quando sembra possibile riavvolgere il cervello e tirare le somme di quanto accaduto.
Ripartendo da Mulholland Drive, appare evidente come Lynch insista ancor di più su quella dis-misura della narrazione che aveva disorientato i più. In INLAND EMPIRE, infatti, la rottura data dall’apertura del cubo blu non avviene dopo due ore di film e a venti minuti dalla fine, ma dopo solo un’ora, forse cinquanta minuti, dall’inizio del film. E si tratta di una rottura che non consente ritorni, neanche quando sembra possibile riavvolgere il cervello e tirare le somme di quanto accaduto.
Come in Mulholland Drive, il lavoro sul significante è definitivo, senza scampo, senza timore di incorrere in fraintendimenti: ai flashback si aggiungono i flash-forward, l’apparenza di un punto di riferimento della narrazione si scioglie presto nel mare della visione e nella confusione dei sensi.
Come in Mulholland Drive (e come in tutto il cinema del Nostro), l’oggetto del film è l’identità umana: contorta, onirica, minacciata. Peccato che a differenza del precedente lavoro qui non serva definire più di tanto lo stato delle cose, e sia sufficiente gettare poche esche in mano allo spettatore per fornire le carte necessarie alla decodifica. E poi la matrioska si moltiplica, rendendo tutto più contorto ma anche più affascinante. Nikki è un’attrice, il film che sta per fare un remake, nell’originale gli attori sono stati uccisi; pare però che a questo primo livello di confusione se ne aggiunga un altro: Nikki si innamora infatti di Devon, il suo collega di set, proprio come la protagonista del film che stanno interpretando insieme. Il muro tra realtà e finzione si scioglie, e da lì si parte per un viaggio senza confini, senza pareti e senza fronzoli, nella mente di Nikki.
Come Mulholland Drive, anche INLAND EMPIRE è un film su Hollywood, sul dramma del cinema, su un mondo fatto di attori che scopano, registi che non sanno dove parare, assistenti che elemosinano spicci. Un mondo che vede ogni dramma consumarsi tra le stelle fissate a terra, nel viale più famoso del mondo, e che solo in questa misura può far ammettere all’attrice Nikki di essere una puttana.
Come Mulholland Drive, INLAND EMPIRE è abitato da figure dell’immaginario, mai buone e sempre terrificanti, che sbucano come funghi ma che non hanno bisogno di una seconda apparizione per spiegare il proprio manifestarsi.
Come in Mulholland Drive (e pressoché tutto il cinema del Nostro), abbiamo un prologo nettamente separato dal resto del film, senza titoli di testa, in cui qualcosa emerge, si pone, affiora – senza senso e senza forma, inquietante e allo stesso tempo falsamente determinante.
Come Mulholland Drive, l’umorismo non-sense guida la vicenda e calibra la misura stessa del sublime intrinseco ai misteri proposti (come ebbe a dire Slavoj Zizek): le due cose non sono dissociabili, semmai sono una la conseguenza dell’altra, e non può esserci sublimità del film senza il ridicolo che appartiene ai dialoghi. Quasi una scusa, una giustificazione: vedere nell’assurdità di alcune battute e situazioni la chiave di lettura per accedere al complesso dell’opera…
Come Mulholland Drive, anche INLAND EMPIRE è costruito su inquietanti movimenti senza senso tra le pareti dell’inconscio, nel buio sporco di un’immagine digitale che accresce l’ansia caratteristica dai travelling ricorrenti – che non portano da nessuna parte, che sono pronti a farti balzare sulla sedia senza averti mostrato nulla, che spaventano solo grazie al loro incedere incerto.
Contro Mulholland Drive, e contro tutto il cinema suo e nostro degli ultimi anni, INLAND EMPIRE sposa con coraggio e ostinazione difficile da accettare un’estetica del brutto che mai ci saremmo aspettati da un autore come Lynch, tanto raffinato nel colorare i suoi film: una non-estetica violenta che rompe le inquadrature, che tiene i soggetti fuori fuoco, che sovraespone la luce, che zooma in maniera impropria, che risolve tutto con rozzi grandangoli. Un’estetica del brutto video che si coniuga però alla perfezione con altri aspetti del linguaggio abituale di Lynch, fatto di giochi di luce e ombre destabilizzanti, di sfondature audio insostenibili all’orecchio (e al cervello).
Il terrore prodotto dal film supera così l’immaginazione, pur riconoscendo il limite intrinseco ad un’operazione a tal punto contraddittoria: ciò che manca ad INLAND EMPIRE è proprio la fascinazione dell’immagine cinematografica, la profondità e il volume della pellicola, le sue sfumature e la sua tridimensionalità. Per questo motivo il film non ti resta attaccato come i capolavori che il Nostro ha prodotto nel suo passato recente e lontano. Per questo anche i momenti più memorabili del film (mi riferisco a quei venti minuti di passaggio dalla realtà del film che stanno girando all’universo mentale di Nikki) non ti turbano come vorrebbero ma restano mirabili trovate visuali e narrative.
Stranamente INLAND EMPIRE è un film senza cuore, anche se sembra fatto solo con i sensi. Il senso, il significato, c’è eccome, ed è tutto nascosto nella personalità/identità molteplice che solo un’attrice come Laura Dern poteva donare all’attricetta in cerca di riscatto Nikki Grace. Da qui la trovata più efficace ed inquietante del film, le otto prostitute/ballerine che incarnano alla perfezione, nei loro balletti e nei loro discorsi fatui, la schizoide personalità di Nikki.
E comunque, nonostante l’azzardo e tutto sommato l’incompiutezza dell’operazione, forse troppo radicale per restare in piedi da sola, resta la coerenza di un autore unico che è risalito fino alle proprie origini, a quel pittorico cinema di sensi e d’avanguardia della sua giovinezza artistica (tante le affinità con The Grandmother, corto di 30’ del 1970).
E soprattutto resta la lucidità di un uomo che sa guardare al proprio mondo nel fluire del tempo che passa, scoprendo nei traumi e nei buchi della società in cui vive il motivo per fare cinema: in questo caso, allora, INLAND EMPIRE è il film necessario su una società dello spettacolo che ha frantumato a tal punto il proprio immaginario da rendere impercettibile, forse addirittura sfondandolo, bucato come la seta che viene lacerata da una sigaretta accesa, il confine tra il Dentro e il Fuori, l’Io e il Mondo.